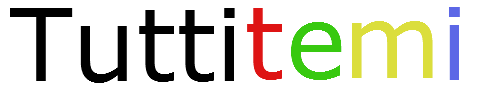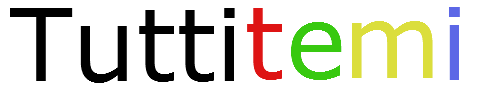| |
Storia del conflitto che ha portato alla disgregazione dei Balcani
Le origini delle tensioni tra le diverse etnie della Jugoslavia «Quando si parla
della ex-Jugoslavia si suole dire che vi convivevano sei gruppi nazionali:
serbi,
croati, macedoni, montenegrini, sloveni e musulmani bosniaci, oltre una miriade
di gruppi etnici minori quali albanesi, ungheresi, italiani, bulgari, romeni,
slovacchi, cechi, ucraini, rom, turchi;
che vi si usavano tre lingue ufficiali e due alfabeti;
che vi si praticavano le
religioni cattolica,
ortodossa musulmana.
Politicamente era uno Stato federale diviso in sei
repubbliche e due
province autonome, retto da un regime socialista, diverso però da tutti gli
altri socialismi reali.
Questa lucida sintesi fatta dallo storico Jože Pirjvec mostra la complessa
realtà socio-politica della regione balcanica; realtà che riesce a sopravvivere fino a quando una
personalità forte e carismatica
come quella del maresciallo Tito difende, conserva, impone, attraverso
l’apparato comunista, gli
equilibri essenziali per una pacifica convivenza.
regione balcanica; realtà che riesce a sopravvivere fino a quando una
personalità forte e carismatica
come quella del maresciallo Tito difende, conserva, impone, attraverso
l’apparato comunista, gli
equilibri essenziali per una pacifica convivenza.
Le guerre che insanguinano la Jugoslavia alla fine del secolo scorso hanno,
quindi, come immediato
background, una situazione di calma apparente, costruita nel corso degli anni da
un regime che,
tuttavia, non aveva cancellato le divisioni di carattere storico, culturale,
religioso che da sempre
distinguevano gli slavi del sud.
Nell’età moderna, la storia della penisola balcanica fu fortemente improntata
dai giochi di forza di
due imperi: quello cristiano degli Asburgo e quello islamico degli Ottomani.
Gli Ottomani, che a partire dalla seconda metà del XV secolo imposero un
lunghissimo dominio,
influenzarono in maniera determinante i popoli balcanici soprattutto in Bosnia,
dove maggiormente
si diffuse la cultura e la religione islamica.
Ad ostacolare la loro avanzata in
Occidente difendendo,
allo stesso tempo, i propri possedimenti e la cristianità dell’Europa, furono
gli imperatori d’Asburgo
che non nascondevano il desiderio di espandersi a loro volta nei Balcani.
Fin dal Seicento, i sovrani d’Austria avevano creato una sorta di baluardo
difensivo tra la Croazia e
la Bosnia per impedire lo sconfinamento dei turchi. Quella regione di confine,
chiamata Krajina,
venne popolata fin da allora da coloni di origine serba e religione ortodossa
che all’occorrenza
avrebbero dovuto fornire un sostegno militare di difesa: «si formò così una
popolazione guerriera,
divenuta col tempo uno dei punti di forza dell’esercito asburgico, fatalmente
estranea alla
maggioranza croata in cui era inserita».
Tra la fine del Settecento e i primi dell’Ottocento, si diffusero tra gli
intellettuali serbi e croati nuovi
ideali che se per certi versi s’ispiravano all’Illuminismo e alla sua ansia
riformatrice, per altri erano
fortemente influenzati dal nascente Romanticismo di area tedesca che aveva nel
nazionalismo e
nell’indipendenza dei popoli oppressi due dei suoi punti fermi. Approfittando
della profonda
decadenza in cui ormai versava l’impero ottomano, i serbi organizzarono negli
anni 1804 e 1815
due rivolte per scrollarsi di dosso il potere del sultano; il risultato di
queste insurrezioni fu la
creazione nel periodo 1817-30 di un piccolo principato semiautonomo retto da un
despota locale: Miloš Obrenovic.
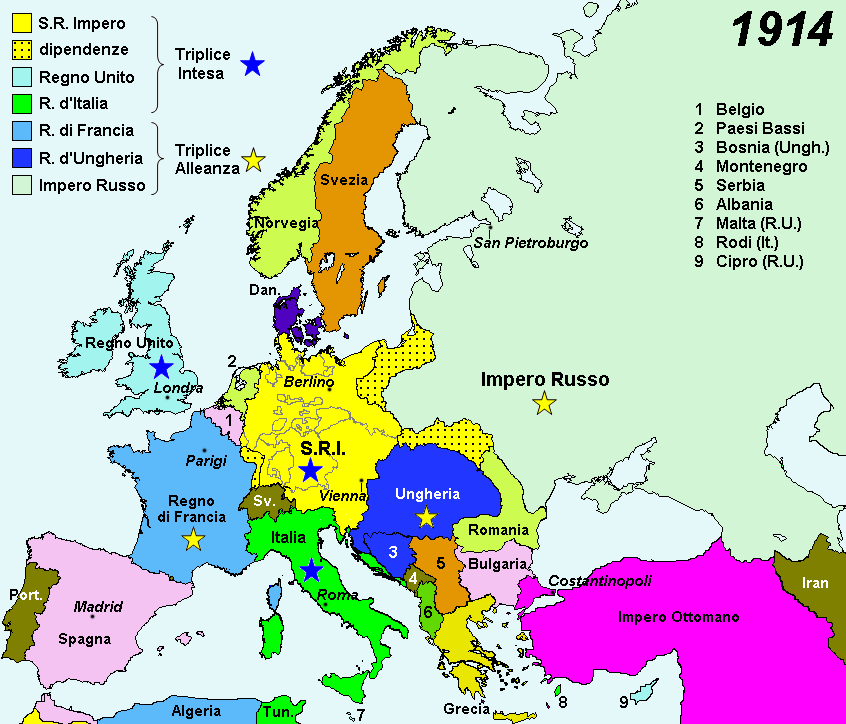 Intanto si andava formando una sorta di coscienza ‘jugoslava’ che riteneva
possibile unire i popoli
balcanici in un unico stato sovrano e indipendente: «In questo clima di fervore
intellettuale
incominciò a prendere corpo l’idea jugoslava, la quale nacque dalla convinzione,
di matrice
illuminista, che data l’affinità del loro lessico, sarebbero bastate una lingua
letteraria e una Intanto si andava formando una sorta di coscienza ‘jugoslava’ che riteneva
possibile unire i popoli
balcanici in un unico stato sovrano e indipendente: «In questo clima di fervore
intellettuale
incominciò a prendere corpo l’idea jugoslava, la quale nacque dalla convinzione,
di matrice
illuminista, che data l’affinità del loro lessico, sarebbero bastate una lingua
letteraria e una
cultura comune per far scoprire ai popoli jugoslavi la loro parentela,
fondendoli in un unico Stato.
Portavoce di tale programma fu Ljudevit Gaj, fondatore del ‘movimento illirico’
(gli slavi
meridionali erano considerati i discendenti degli antichi illiri), che negli
anni Trenta e Quaranta
dell’Ottocento, ebbe ampia diffusione nell’ambito croato».
I difficili rapporti tra l’elemento serbo e il governo di Instabul si
trasformarono in una questione internazionale nel 1877, quando la Russia
intervenne a fianco della Serbia in un nuovo conflitto. Al
Congresso di Berlino del 1878, convocato dal cancelliere Bismarck dopo la
vittoria dello zar sulla
Turchia, le maggiori potenze europee decisero di porre la Bosnia-Erzegovina
sotto
l’amministrazione austriaca per bilanciare l’influenza che la Russia stava
assumendo nella regione
balcanica. Altro importante risultato del Congresso fu il pieno riconoscimento
del regno di Serbia
dove ben presto si diffuse un nazionalismo sempre più esasperato.
Quando nel
1908 la Bosnia
venne annessa all’Austria-Ungheria anche formalmente, i malumori di serbi e
musulmani
aumentarono in quanto «tale gesto fu interpretato come una sfida alle propria
aspirazioni al dominio della provincia, dando ulteriore impulso alle reciproche
animosità.
Dopo le due guerre balcaniche (1912-13), la Serbia riuscì ad annettersi parte
della Macedonia - la vallata del Vardar e la regione del Kosovo - abitata prevalentemente da albanesi.
Per impedire al
nuovo stato di divenire troppo potente, l’Austria-Ungheria e l’Italia favorirono
la nascita del
principato d’Albania, che doveva impedire alla Serbia lo sbocco nell’Adriatico.
Poiché non si tenne
in nessun conto il principio etnico, gli albanesi si trovarono divisi tra
diverse entità statali.
Durante il primo conflitto mondiale, i popoli jugoslavi si trovarono su opposte
barricate: sloveni,
croati, musulmani di Bosnia, come pure i serbi della Croazia della Vojvodina e
della Bosnia, sotto
le bandiere asburgiche; serbi e montenegrini furono invece alleati dell’Intesa.
Alla fine della
guerra, croati e sloveni, che si trovavano in una posizione piuttosto ambigua in
quanto non si sapeva
se considerarli nemici sconfitti o popoli liberati dal dominio di Vienna,
decisero di aggregarsi al
regno serbo «al quale guardavano da tempo come ad una possibile alternativa per
sottrarsi al
dominio ungherese e austro-tedesco.
Affrettatamente e senza precisi accordi
preliminari fu dunque
proclamata l’unione dei tre popoli sotto la dinastia dei Karadjordjevic,
soluzione che si sarebbe
dimostrata ben presto assai problematica per il manifestarsi di inattesi
conflitti d’interesse, di
tradizioni storiche e culturali. Mentre i serbi vedevano il nuovo regno come un
ampliamento del
loro vecchio stato ed erano insensibili alle richieste d’autonomia provenienti
da Zagabria e Lubiana, i croati e gli sloveni lo avvertivano come una compagine
sostanzialmente estranea ai loro
interessi e alla loro mentalità. Ne derivò tutta una serie di scontri e
violenze, culminati nell’ottobre
1934 con l’assassinio a Marsiglia del re Alessandro, in viaggio ufficiale in
Francia, organizzato da
Ante Pavelic, capo del movimento di estrema destra croato degli ‘ustascia’. Lubiana, i croati e gli sloveni lo avvertivano come una compagine
sostanzialmente estranea ai loro
interessi e alla loro mentalità. Ne derivò tutta una serie di scontri e
violenze, culminati nell’ottobre
1934 con l’assassinio a Marsiglia del re Alessandro, in viaggio ufficiale in
Francia, organizzato da
Ante Pavelic, capo del movimento di estrema destra croato degli ‘ustascia’.
Difficile era anche il rapporto tra i musulmani di Bosnia e il governo di
Belgrado soprattutto perché
nell’ambito di una vasta riforma agraria venne tolta ai feudatari musulmani
tutta la terra possibile
che fu ridistribuita a nuovi proprietari in maggioranza serbi.
A complicare
ulteriormente la
situazione, non mancarono le rivendicazioni sulla Bosnia-Erzegovina da parte dei
croati, non solo
perché sul suo territorio erano stanziati da sempre dei loro connazionali, ma
anche perché gli stessi
musulmani venivano considerati dei cattolici convertiti durante il dominio
ottomano.
Nei confronti delle altre etnie, albanese e macedone, il governo di Belgrado
negò, «fin dalla
conquista delle loro terre nel corso delle guerre balcaniche, qualsiasi diritto
all’individualità
nazionale e culturale. Essi furono considerati dai nuovi padroni una popolazione
sottosviluppata
da assimilare o scacciare il prima possibile. A tal fine non si andò per il
sottile, scatenando contro i
macedoni e in maniera ancora più brutale contro gli albanesi, avvertiti del
tutto estranei per stirpe
e fede musulmana o cattolica, un vero e proprio regime di terrore, che causò
numerose vittime
guastando irrimediabilmente i rapporti interetnici.
La convivenza tra le diverse etnie divenne addirittura drammatica durante la
seconda guerra
mondiale, quando la Jugoslavia venne occupata dagli eserciti stranieri e, in
Croazia, si formò lo
stato autonomo filofascista di Ante Pavelic che inglobò anche la
Bosnia-Erzegovina. Gli ‘ustascia’di Pavelic portarono avanti una politica fortemente discriminatoria nei
confronti della minoranza
serba che subì deportazioni, massacri e conversioni forzate al cattolicesimo.
Intanto cominciava ad organizzarsi la resistenza contro le truppe di
occupazione, in prevalenza
tedesche e italiane; a partire dall’estate del 1941, due formazioni, diverse per
ideologia,
composizione etnica, diffusione nel territorio, iniziarono la lotta di
liberazione.
Si trattava dei
cetnici di Draža Mihailovic e dei partigiani comunisti di Tito: i primi erano
serbi fedeli al governo e
al giovane re Pietro Karadjordjevic in esilio a Londra; i secondi aspiravano a
realizzare uno stato
federale di tipo socialista, sul modello dell’URSS, una volta liberati dal
tallone nazi-fascista.
Alla fine «il movimento partigiano uscì vittorioso dal marasma della seconda
guerra mondiale
perché si mostrò capace di diffondersi in gran parte del paese ma soprattutto
perché a partire dal
1943, fu considerato dai britannici l’unico in grado di combattere veramente i
tedeschi e aiutato di conseguenza con armi e rifornimenti di ogni tipo.
Terminato il conflitto, Tito riuscì a creare un organismo federale comprendente
sei repubbliche
(Serbia, Croazia, Montenegro, Macedonia, Bosnia, Slovenia ) e due province
autonome (Kosovo e
Vojvodina) che avevano fatto parte integrante del regno di Serbia. Il distacco
delle due province
venne considerato dai serbi come un tradimento e una sopraffazione da parte dei
comunisti: «Al
momento non fu ovviamente possibile nessun tipo di protesta, dato il totale
controllo che il partito,
attraverso l’esercito e la polizia segreta, esercitava sulla società. Solo
decenni più tardi la protesta
avrebbe trovato espressione nell’accusa a Tito e ai suoi di aver voluto una
Serbia debole per avere un Jugoslavia forte».
Nel 1948 avvenne un fatto piuttosto traumatico per l’universo socialista: il
partito comunista
jugoslavo, a cui probabilmente i diktat del Cremlino andavano stretti, venne
espulso dal
Cominform, l’organismo di consultazione fra partiti comunisti europei. La
Jugoslavia di Tito usciva
dall’orbita sovietica per portare avanti un percorso di stato non allineato.
Malgrado lo stretto controllo del regime, le rivendicazioni delle varie etnie,
soprattutto di quelle
maggiormente svantaggiate, non vennero meno. Quando nel 1968 le truppe del Patto
di Varsavia,
che avevano già invaso la Cecoslovacchia per porre fine alla Primavera di Praga,
sembravano
minacciare un intervento contro Tito, i kosovari decisero di sfruttare il
difficile momento per otten ere maggiori diritti e il distacco completo dalla Serbia. ere maggiori diritti e il distacco completo dalla Serbia.
Per porre un
limite alle rimostranze, nel
1974 venne promulgata una nuova costituzione che garantiva alle province
autonome della Vojvodina e del Kosovo maggiori libertà e possibilità di autogestione, impedendo
in pratica alla
Serbia qualunque ingerenza. Inoltre, «secondo la formula rituale, presa a
prestito da Lenin, alle
repubbliche – ma non alle due province– veniva riconosciuto il diritto alla
secessione e
all’autodeterminazione.
Alla morte di Tito, avvenuta il 4 maggio 1980, la Jugoslavia si trovò ad
affrontare le sue tante
contraddizioni senza che la forza coesiva del partito comunista potesse
impedirne la disgregazione.
Ancora una volta la spia del malessere si accese nel Kosovo dove, nel marzo
1981, la popolazione
di etnia albanese tentò l’ennesima rivolta contro la minoranza serba chiedendo
il distacco definitivo
da Belgrado. La questione del Kosovo era estremamente delicata perché per i
serbi quella regione
era storicamente essenziale per la loro identità nazionale. Pertanto, non solo
la rivolta venne
repressa facendo intervenire l’Armata popolare, ma si scatenò un violento
nazionalismo che mise in
allarme le altre etnie della Federazione.
Se da una parte Croazia e Slovenia incominciavano a pianificare la secessione,
dall’altra
aumentavano i timori dei serbi di vedere il loro popolo smembrato in tre
indipendenti entità statali: la Serbia, la Croazia e la Bosnia Erzegovina.
Frutto di questo clima esasperato fu il Memorandum elaborato da un gruppo di
intellettuali
dell’Accademia delle Scienze e delle Arti di Belgrado nel 1986: Esso si basava
su tre
considerazioni fondamentali: affermava che il popolo serbo nella sua storia si
era sempre
sacrificato per gli altri, ma, nonostante ciò, era stato sempre derubato dei
frutti delle proprie vittorie e che, anche nella Jugoslavia socialista, come già nei secoli
precedenti, era esposto a un
genocidio strisciante. “A nessun popolo della Jugoslavia viene negata in maniera
massiccia la sua
identità culturale e spirituale come a quello serbo”. Per ovviare a tale triste
situazione il
Memorandum chiedeva il ripristino della piena sovranità di Belgrado su tutto il
territorio
repubblicano (in pratica l’abolizione dell’autonomia del Kosovo e della
Vojvodina), nonché l’instaurazione della piena integrità nazionale e culturale
serba a prescindere dalla Repubblica o dalla Provincia in cui vive".
Alla fine degli anni Ottanta, chi seppe abilmente influenzare l’opinione
pubblica in Serbia in senso
spiccatamente nazionalista fu Slobodan Milosevic che, dal 1987, si trovava a
capo del partito
comunista serbo. Facendosi promotore della difesa dei valori e degli interessi
del popolo serbo,
riuscì a portare dalla sua parte non solo i nazionalisti più accesi ma la stessa
chiesa ortodossa e,
soprattutto, l’Armata popolare i cui ufficiali erano in prevalenza serbi e
montenegrini. Non contento
del suo successo personale in patria, dove oramai veniva chiamato vožd (duce),
cercò di manovrare
anche la politica del Montenegro e delle province autonome rovesciando, con
l’aiuto dei servizi
segreti, i rispettivi governi e sostituendoli con altri a lui favorevoli,
malgrado la forte opposizione
degli albanesi del Kosovo. Incominciò, inoltre, a influenzare la popolazione
serba di Croazia e
della Bosnia con il progetto della Grande Serbia il cui fine era “riunire tutte
le terre serbe sotto un
unico tetto”.
Non si trattava solo di propaganda ideologica: segretamente i
serbi delle repubbliche
vicine incominciarono ad armarsi. Mentre si andava sgretolando il sistema comunista nell’Europa orientale, in
Slovenia e Croazia
furono indette le prime libere elezioni, proprio all’indomani dell’abbattimento
del muro di Berlino.
Se in Slovenia gli ex comunisti furono sconfitti da una coalizione di
orientamento cattolico-liberale,
in Croazia divenne il nuovo protagonista della vita politica un ex partigiano di
Tito, Franjo
Tudjman.
Mentre si andava sgretolando il sistema comunista nell’Europa orientale, in
Slovenia e Croazia
furono indette le prime libere elezioni, proprio all’indomani dell’abbattimento
del muro di Berlino.
Se in Slovenia gli ex comunisti furono sconfitti da una coalizione di
orientamento cattolico-liberale,
in Croazia divenne il nuovo protagonista della vita politica un ex partigiano di
Tito, Franjo
Tudjman.
Leader dell’Unione democratica croata, Tudjman si fece portavoce di un
nazionalismo
non meno becero di quello serbo.
Appena al potere, invece di tranquillizzare la
minoranza serba
presente nella sua repubblica, prese una serie di misure miranti a diminuirne il
peso nella vita
pubblica e nell’amministrazione, dando il via ad un’ondata di licenziamenti e
atti discriminatori.
Né si limitò a questo: nella nuova costituzione, approvata nel dicembre del
1990, all’etnia serba, circa il 12% della popolazione della Croazia, veniva tolto lo status di nazione
costituente la
Repubblica, relegandola a livello di una qualsiasi minoranza etnica. Tale
attitudine, accompagnata
dal recupero di simboli nazionali croati, cui gli ustascia avevano impresso il
marchio infame della
loro ideologia, e dalla riabilitazione dello stato indipendente croato di
Pavelic, suscitò tra i serbi
un vivissimo allarme che Milosevic, eletto nel dicembre del 1989 presidente
della Serbia, seppe
sfruttare con molta accortezza.
Era come gettare benzina sul fuoco. Incoraggiato dall’indifferenza
dell’Occidente dove nessuno si
curava di ciò che stava succedendo in Jugoslavia, Milosevic non solo promosse
embarghi
economici contro le repubbliche di Slovenia e Croazia, ma fomentò un movimento
di resistenza al
legittimo governo di Zagabria nella cittadina di Knin dove la popolazione era in
maggioranza serba.
Nell’agosto del 1990, la rivolta dei serbi di Knin si estese a tutta la Krajina
dove si richiedeva
l’indipendenza dalla Croazia per annettersi alla Serbia.
Il 28 febbraio 1991 venne proclamata la Provincia autonoma serba della Krajina.
Ogni tentativo da
parte di Zagabria di ristabilire il proprio controllo sulle aree coinvolte fallì
per l’intervento
dell’Armata popolare a favore dei rivoltosi.
La guerra in Slovenia. 1991
La dissoluzione della Jugoslavia avviene in un momento in cui la situazione
internazionale non si
presenta affatto favorevole ai movimenti indipendentisti. Sono tanti gli
avvenimenti, e tutti di
importanza capitale, che in quell’inizio di decennio coinvolgono il mondo
intero: la prima guerra
del Golfo, l’unificazione della Germania, lo sfacelo dell’impero sovietico, il
disarmo nucleare.
L’Europa e gli Stati Uniti non vogliono che si crei un’altra area di crisi nei
Balcani. Tutti si
augurano che il governo federale riesca a riportare alla ragione le repubbliche
“ribelli” e lasciano,
di fatto, campo libero a Milosevic.
Nei circoli governativi internazionali era
infatti assai diffusa la
convinzione che la Jugoslavia alla fin fine non fosse altro che una Grande
Serbia da preservare
nella sua integrità, a costo di lasciarla in balia di Slobodan Milosevic e
dell’Armata popolare, capeggiata da un gruppo di ufficiali vetero-comunisti.
La volontà di
conservare intorno al
nucleo serbo i territori che vi gravitavano era condizionata dalla
consapevolezza che la Jugoslavia
aveva un preciso ruolo strategico nel mantenimento dei delicati equilibri
militari e geopolitici
dell’intero Sud-est europeo. Costituiva inoltre un importante nodo di
comunicazione tra il mar
Egeo e il bacino danubiano che bisognava conservare se non altro per non
interrompere i flussi
commerciali via terra tra il grosso della CEE e la Grecia».
La situazione intanto andava precipitando: il 25 giugno 1991, i parlamenti di
Slovenia e Croazia
proclamarono l’indipendenza dei loro paesi.
Il governo di Lubiana ordinò ai poliziotti e doganieri sloveni di prendere il
controllo delle frontiere
con l’Italia, l’Austria e l’Ungheria ma posti di blocco vennero istituiti anche
a confine con la
Croazia.
I simboli federali furono sostituiti con quelli nazionali.
Il parlamento federale di Belgrado, privo ormai dei suoi membri sloveni e
croati, si riunì e dichiarò illegittima la dichiarazione di indipendenza.
Il 26 giugno, intanto, si svolse
nella piazza principale
di Lubiana la solenne cerimonia, nel corso della quale fu proclamata
l’indipendenza della Slovenia
e sostituito il tricolore jugoslavo con la nuova bandiera.
Il governo federale pensava di liquidare la faccenda nell’arco di ventiquattro
ore facendo intervenire
l’Armata popolare nei punti strategici della Slovenia.
Ma la Difesa
territoriale, formata da forze
armate volute dallo stesso Tito per assicurarsi il controllo del territorio,
seppe opporre una valida
resistenza all’esercito. Dopo aver tentato ancora una volta di evitare lo
scontro armato, telefonando
al presidente del Consiglio federale Markovic per indurlo a fermare l’offensiva,
il presidente
sloveno Kucan diede l’ordine di sparare.
Gli ufficiali dell’Armata popolare sottovalutarono imprudentemente
l’organizzazione della Difesa
territoriale, alla quale loro stessi avevano contribuito durante il regime, non
riuscendo a contrastarla
efficacemente.
L’azione militare, infatti, si concluse per loro con una
clamorosa umiliazione che
mise in crisi il governo di Markovic a cui l’Occidente aveva affidato il compito
di risolvere la
questione senza intervenire direttamente.
Ora Markovic non aveva altra scelta che accettare l’ingerenza della Comunità
europea per risolvere
i problemi interni del paese.
Una trojka, formata dal ministro degli Esteri del paese che aveva la presidenza
della Comunità, dal
suo predecessore e dal suo successore, venne inviata a Belgrado per cercare di
risolvere la crisi
puntando ancora sull’integrità della Jugoslavia.
Vista l’irremovibilità degli
Sloveni a cedere sulla
questione dell’indipendenza, si prese tempo con una moratoria di tre mesi che
“congelava” la
separazione da Belgrado.
Intanto, la posizione del governo federale nei confronti della Slovenia andava
mutando per
influenza della stessa Serbia di Milosevic che non vedeva negativamente
“l’amputazione” della
Slovenia, dove n on vivevano minoranze serbe. Così, ai primi di luglio, l’Armata
popolare cominciò
a ritirarsi dalla Slovenia per dirigersi verso la Croazia. on vivevano minoranze serbe. Così, ai primi di luglio, l’Armata
popolare cominciò
a ritirarsi dalla Slovenia per dirigersi verso la Croazia.
Il 7 luglio 1991, i rappresentanti della Comunità europea e delle parti in lotta
si riunirono a Brioni
per raggiungere un accordo con cui si sarebbe sancita la fine della guerra in
Slovenia.
Il conflitto durò dieci giorni e si concluse con un bilancio di 74 morti e 280
feriti, in maggioranza
appartenenti all’Armata popolare jugoslava.
La guerra in Croazia
A preparare la guerra contro la Croazia ci fu un’attiva propaganda da parte di
Belgrado in cui il
passato veniva strumentalizzato per fomentare nella popolazione serba l’odio e
il timore verso i
croati e il nuovo governo di Zagabria.
D’altra parte, i provvedimenti che Tudjman aveva preso, appena giunto al potere,
non erano i più
idonei a tranquillizzare la minoranza serba della repubblica croata.
Ai servizi
segreti e all’Armata
popolare non fu dunque difficile costituire fin dal 1990, nelle aree prescelte,
gruppi armati per
spingerli a lottare contro gli odiati ustascia e dimostrare all’opinione
pubblica locale e
internazionale che il “popolo serbo minacciato” si era levato spontaneamente a
propria difesa, come già mezzo secolo prima ai tempi dello stato indipendente
croato.
Essendo ancora in atto la guerra contro la Slovenia, alla fine del giugno1991
venne attaccata la
Slavonia orientale, regione croata a confine con la Serbia. Ben presto le azioni
militari si estesero ad
altri territori tra cui la Dalmazia con l’area di Dubrovnik dove i serbi
rappresentavano una
minoranza.
Punto di forza dei serbi era la Provincia autonoma della Krajina che aveva
disconosciuto il governo
di Zagabria fin dal febbraio 1991 chiedendo l’annessione alla Serbia. I croati,
temendo ritorsioni,
cominciarono ad abbandonare la regione.
Ma il teatro principale della guerra restava la Slavonia dove furono attaccate
le città di Osijek,
Il 4 agosto a Dalj, poco distante da Vukovar, si ebbe uno
dei primi esempi di
‘pulizia etnica’ di grandi proporzioni.
180 croati si rifugiano nella chiesa
locale, tra loro Sjepan
Penic, cronista del quotidiano croato “Glas Slavonije”. I serbi intimano la
resa, un primo gruppo
di sessanta persone esce dalla chiesa ed è trucidato sul posto. I rimanenti
vengono portati nello
stadio e fucilati. I loro corpi restano per tre giorni in vista e poi vengono
bruciati.
Ancora una volta l’Armata popolare venne utilizzata come forza di aggressione,
non solo contro
militari ma anche contro civili inermi. Tuttavia, a causa della renitenza alla
leva, l’esercito federale
era piuttosto sguarnito, perciò Belgrado fece ricorso alla polizia locale, alla
Difesa territoriale e,
soprattutto, a forze paramilitari adeguatamente addestrate fin dalla primavera
precedente. Queste si
distinsero ben presto per la loro ferocia; tra i gruppi che diverranno
tristemente famosi ci fu quello
delle Tigri il cui comandante Arkan, ex capo della tifoseria della Stella Rossa
di Belgrado e killer
dei servizi segreti jugoslavi, era un uomo fidato di Mi losevic. losevic.
Saranno i suoi
mercenari, insieme ad
altri gruppi paramilitari, ad entrare per primi a Vukovar dopo un assedio durato
più di tre mesi, e a
macchiarsi di crimini inauditi come l’uccisione di 261 persone, tra medici e
feriti ricoverati nell’ospedale locale.
In un quadro estremamente drammatico fin dai primi atti del conflitto, la
comunità internazionale si
dimostrò impreparata a gestire la crisi anche a causa delle divisioni che
tenevano le potenze europee
su posizioni nettamente distanti le une dalle altre per motivi di opportunità
politica. Se la Germania,
attraverso il suo ministro degli Esteri Genscher, premeva per il riconoscimento
di Slovenia e
Croazia, Francia e Inghilterra dimostravano a tal proposito la loro contrarietà
in quanto preoccupate
di una possibile espansione dell’influenza tedesca nei Balcani. Di queste
divisioni e incertezze
seppe approfittare Milosevic che continuava a negare di essere in guerra con la
Croazia, sostenendo
che gli interventi militari contro i croati avevano l’esclusivo scopo di
difendere i serbi dalla
persecuzione degli ustascia. Grazie alla propaganda, questa era la convinzione
di buona parte
dell’opinione pubblica serba e della stessa Chiesa ortodossa, guidata dal
patriarca Pavle.
Per capire quanto fosse miope la visione che gli europei avevano della questione
jugoslava basti
dire che il ministro degli Esteri olandese Van den Broek considerava Milosevic
il miglior politico
europeo, nel tragico luglio del 1991.
Intanto, i ministri degli esteri della Comunità europea, riuniti a Bruxelles,
promisero di inviare in
Croazia cinquecento osservatori e riconobbero l’inviolabilità delle frontiere
tra le diverse
repubbliche jugoslave.
Nella notte tra il 19 e il 20 agosto venne messo in atto a Mosca il golpe contro
Gorbaciov che fece
sperare a Milosevic un ritorno al regime comunista nell’URSS, fatto che avrebbe
potuto favorire la
ricostituzione di una Jugoslavia socialista a netta supremazia serba.
Nell’immediato, l’insurrezione
russa allentò il controllo dell’Occidente sugli avvenimenti jugoslavi,
consentendo ai serbi di
inasprire l’offensiva contro la Croazia. È di quei giorni l’inizio dell’assedio
di Vukovar, importante
porto fluviale sul Danubio che in quel tratto segna la frontiera croata-serba.
L’assedio fu durissimo perché i croati, che rappresentavano la maggioranza della
popolazione,
contrapposero una valida resistenza, coadiuvati da forze paramilitari. Da parte
loro gli assedianti
non si limitarono all’uso di blindati e artiglieria pesante ma ricorsero, come
poi succederà a
Sarajevo, ai cecchini che colpivano civili inermi nelle strade, scuole, asili,
ospedali.
Quando le armate serbe conquistarono la città dopo ottantasei giorni d’assedio,
i civili morti erano
circa quattromila.
Il 6 settembre si aprì all’Aia, presieduta dall’inglese Lord Carrington, la
conferenza di pace voluta
dalla Comunità europea per risolvere il conflitto in Jugoslavia. In realtà, la
conferenza servì a
mettere ancora una volta in evidenza le solite divisioni. Alla fine, prevalse la
proposta franco-britannica
di chiedere l’intervento dell’ONU, decretando in questo modo l’incapacità degli
europei
di risolvere autonomamente i propri problemi.
Il Consiglio di Sicurezza non ritenne opportuno inviare un contingente di pace
come richiesto dalla
Comunità europea anche per la contrarietà espressa dai serbi riguardo ogni
intervento di forze
esterne in territorio jugoslavo; pertanto si limitò a decretare, con la
Risoluzione 713, «un generale e
totale embargo su tutte le forniture di armi e materiale bellico alla
Jugoslavia». Di fatto questo
provvedimento avvantaggiava la Serbia che aveva il controllo dell’Armata
popolare e di gran parte
dell’industria bellica, senza contare che da tempo aveva armato i villaggi serbi
delle altre
repubbliche. Milosevic rafforzò così l’offensiva contro la Slavonia e la
Dalmazia meridionale,
colpendo la stessa cittadina di Dubrovnik, malgrado fosse sotto la tutela
dell’UNESCO.
Intanto, in Bosnia-Erzegovina i serbi incominciarono a favorire la formazione di
‘regioni
autonome’, costituite in base a criteri etnici e strategici e dotate di milizie
locali. Il presidente
bosniaco Izetbegovic, allarmato all’idea di trovarsi alla mercé di Milosevic e
dell’Armata popolare,
propose al parlamento di Sarajevo il progetto di una Bosnia-Erzegovina
indipendente da Belgrado;
il 15 ottobre i deputati croati e musulmani votarono a favore dell’indipendenza
mentre i serbi
abbandonarono l’aula. Tuttavia i croati non si limitarono a dichiararsi
favorevoli alla secessione
dalla Federazione ma crearono l’Unione croata Herceg-Bosna che, per volontà di
Tudjman, verrà
posta sotto la guida di Mate Boban, un personaggio poco rassicurante già
condannato per reati
comuni e agente del controspionaggio dell’Armata popolare.
In dicembre, le regioni autonome di etnia serba si costituirono in Repubblica
serba della Bosnia-Erzegovina, includendovi Sarajevo; come presidente venne scelto il capo del
Partito democratico
serbo, Radovan Karadžic che, riguardo l’indipendenza della Bosnia da Belgrado,
si era in
precedenza così espresso: «State attenti a che gioco giocate. Se ci muoviamo,
l’intero vostro popolo
perirà sull’autostrada dell’inferno».
La dissoluzione della Bosnia era iniziata.
Mentre il conflitto serbo-croato raggiungeva l’acme della violenza, Milosevic e
Tudjman trovavano
un punto di contatto per il loro acceso nazionalismo nell’idea di spartirsi la
Bosnia-Erzegovina per
dare vita a una Grande Serbia e ad una Grande Croazia, sicuri che l’Occidente
non avrebbe
ostacolato i loro piani intervenendo a favore dei musulmani bosniaci.
In dicembre, anche l’inconcludente diplomazia europea arrivò finalmente ad un
accordo: a Bruxelles, i ministri degli esteri comunitari s’impegnarono a riconoscere, entro
il 15 gennaio 1992,
l’indipendenza di tutte le repubbliche jugoslave che avessero fatto richiesta
del riconoscimento, a
patto che si conformassero ad una serie di principi stabiliti in base alle
direttive ONU e della stessa
Ue.
L’ONU, da parte sua, decise l’invio di un contingente di Caschi blu nelle zone
interessate dal
conflitto e affidò a Cyrus Vance l’elaborazione di un piano per l’attuazione
della tregua tra le parti
in lotta.
Il Piano Vance venne accettato da Milosevic e Tudjeman che si preoccuparono di
imporlo ai
rispettivi parlamenti; ciò permise di porre temporaneamente fine al conflitto in
Croazia.
Il 15 gennaio 1992 i paesi dell’Ue, il Vaticano, gli stati baltici, l’Ucraina e
l’Islanda riconobbero
l’indipendenza della Croazia e della Slovenia.
La guerra in Bosnia-Erzegovina. 1992-1995
Alla vigilia della guerra la composizione etnica della Bosnia era così formata:
musulmani 41% della
popolazione; croati 17%; serbi 31%. Le varie etnie erano sparse nel territorio
in modo irregolare,
perciò era praticamente impossibile tracciare dei confini netti come cercherà di
fare la diplomazia
internazionale per porre fine alle violenze. I croati erano concentrati
soprattutto nell’Erzegovina occidentale; l’etnia serba era prevalente nella Bosnia settentrionale e in
quella occidentale. I serbi
bosniaci erano separati dalla madrepatria da territori in cui era molto forte la
presenza della
popolazione musulmana, che doveva essere cacciata via se si voleva ricongiungere
quelle regioni
alla Serbia.
Dopo la creazione dell’Herzeg-Bosna croata e della Repubblica serba di
Bosnia–Erzegovina, solo il
presidente Izetbegovic credeva nella possibilità di uno stato bosniaco unitario
in cui le tre etnie
potessero continuare a convivere pacificamente avendo pari diritti.
La sorte della Bosnia sembrava segnata anche per il fatto che, fin dal periodo
del regime comunista,
nel suo territorio era concentrato il grosso dell’esercito federale e la maggior
parte delle fabbriche
d’armi: i cannoni di Derventa, i fucili di Travnik, i blindati di Novi Travnik,
la più grande fabbrica
di esplosivi della Jugoslavia a Vogošca, i detonatori di Goražde e così via.
Nel
suo saggio sulle
guerre nella ex-Jugoslavia Luca Rastello riporta che:«la repubblica centrale
della Federazione nel
1989 è censita dalle agenzie internazionali come la più alta concentrazione al
mondo di produzione
d’armi al metro quadro».
L’espressione che definisce i Balcani ‘la polveriera d’Europa’ non ha, in questi
anni, un significato
prettamente metaforico.
Intanto, con la Risoluzione 743, l’ONU decise l’invio di caschi blu nella
Krajina e nella Slavonia
orientale per favorire il processo di normalizzazione in Croazia. Nasce così l’UNPROFOR
(United
Nations Protection Force), che avrebbe dovuto concludere la sua missione nel
giro di un anno con
l’impiego di un numero limitato di uomini.
Contro ogni aspettativa il mandato
UNPROFOR si
protrasse invece nel tempo, trasformandosi nell’operazione più costosa delle
Nazioni Unite e
numericamente più consistente: dagli iniziali 14000 caschi blu si arrivò nel ’95
a ben 45000
appartenenti a trentanove nazioni (per non dire di una dozzina di agenzie
speciali e di migliaia di funzionari incaricati di occuparsene).
Con quali risultati l’opinione pubblica internazionale poté presto vedere.
In effetti i caschi blu avevano solo la funzione di controllare il territorio ma
non potevano
intervenire con la forza per difendere i civili in quanto l’uso delle armi era
consentito loro solo per
autodifesa. Perciò, malgrado la loro presenza, i serbi continuarono, in Croazia
come poi in Bosnia, a
praticare la pulizia etnica massacrando la popolazione appartenente a un’etnia
diversa per
conquistare territori e insediarvi propri connazionali.
A onor del vero bisogna
dire che il ricorso alla pulizia etnica non fu una loro prerogativa.
Il 29 febbraio e il 1° marzo 1992 si svolse il referendum che avrebbe dovuto
favorire il
riconoscimento dell’indipendenza della Bosnia da parte della comunità
internazionale.
Boicottato
dai serbi (Karadžic impedì che si aprissero le urne nei territori da lui
controllati), il referendum fu
espressione solo della parte croata e musulmana della popolazione che si
espresse a favore
dell’indipendenza da Belgrado. Con la proclamazione ufficiale dell’indipendenza,
a Sarajevo
incominciarono le azioni di guerriglia, mentre unità paramilitari serbe si
posizionavano sulle alture
intorno alla città dove da tempo erano stati collocati pezzi di artiglieria
pesante da parte dell’Armata
popolare. Malgrado nei giorni 6-7 aprile arrivasse il riconoscimento
dell’indipendenza della
Bosnia–Erzegovina da parte della Comunità europea e degli Stati Uniti, la
situazione nei territori
bosniaci diventava sempre più drammatica.
Sarajevo veniva ormai sistematicamente colpita
con granate lanciate dalle alture circostanti la città, mentre i cecchini,
appostati nei quartieri periferici, colpivano i civili che percorrevano le
strade per recarsi al lavoro o a fare provviste di acqua e cibo.
La violenza
veniva giustificata con il pretesto di dover difendere i cittadini serbi dal
governo di Izetbegovic, come in precedenza dal governo croato di Tujman. In
breve tempo la città venne privata dell’energia elettrica e dell’acqua; le
risorse alimentari scarseggiavano; la popolazione terrorizzata incominciava a
combattere la sua battaglia per la sopravvivenza nell’assedio più lungo che una
città si trovò a subire dalla fine della seconda guerra mondiale: 1300 giorni,
dodicimila morti.
Tra i tanti episodi accaduti, si vogliono ricordare due stragi: la prima
avvenuta all’inizio dell’assedio, la seconda alla fine.
Il 27 maggio 1992, una granata lanciata dalle postazioni serbo-bosniache colpì
un gruppo di civili in fila per prendere il pane; morirono ventidue persone.
Vedran Smailovic, primo violoncellista dell’Orchestra sinfonica di Sarajevo,
assistette alla tragedia dalla finestra della sua casa; nei giorni successivi,
sfidando il fuoco dei cecchini, scese in strada con il suo violoncello e suonò
l’Adagio di Albinoni per ciascuna delle vittime.
Alle 12,30 del 5 febbraio 1994 i serbi lanciarono una granata sul mercato di
Markale, nel cuore della città, a quell’ora affollato di gente. Fu la strage più
grave dall’inizio dell’assedio: 68 persone rimasero uccise, quasi 200 furono
ferite. Tra le vittime, come sempre, tanti bambini.
Tuttavia non era solo la capitale bosniaca a soffrire per l’incalzare di questi
strani, spietati nemici che fino a poco tempo prima condividevano, malgrado le
differenze culturali e religiose, territori, città, istituzioni, l’aria che si
respira.
Nella Bosnia nordorientale, nella valle della Drina, incominciava la
conquista da parte dei serbi e il sistematico allontanamento, fino
all’eliminazione fisica, della popolazione musulmana.
Nel frattempo, a livello internazionale, si dovette registrare un maggiore
coinvolgimento degli Stati Uniti nella crisi balcanica. Fino al 1992, gli USA si
tennero a debita distanza dai problemi europei
per evitare di essere coinvolti nuovamente in una guerra che però, questa volta,
era ben lontana dagli interessi americani.
Tuttavia, con l’avvicendamento
dell’amministrazione Clinton, gli orrori
che oramai venivano denunciati quotidianamente dai media e dagli osservatori
internazionali, cominciarono ad avere una forte presa sull’opinione pubblica
americana, fino a convincere il neo presidente ad intervenire in modo più deciso
per trovare una soluzione al conflitto. Almeno fino a quando non si rese conto
che si stava infilando in un ginepraio dai dubbi risultati di convenienza
politica.
In Bosnia, intanto, si apriva un nuovo fronte di guerra a causa dell’accordo
raggiunto nella cittadina austriaca di Graz da Boban e Karadžic riguardo la
spartizione dei territori bosniaci tra l’Erzeg-Bosna croata e la Repubblica
serba di Bosnia, a danno dei musulmani. Cessava quindi, almeno momentaneamente,
il conflitto tra serbi e croati che si ritrovarono insieme a combattere contro
lo stato unitario voluto da Izetbegovic. Riemergeva il progetto della grande
Serbia, affiancata questa volta da una grande Croazia, avallato dai due
presidenti nazionalisti Milosevic e Tudjman.
Il 9 maggio 1993 la cittadina di Mostar, situata lungo le sponde del fiume
Neretva, venne presa d’assalto dalle truppe croate. Mostar era un esempio di
convivenza tra le etnie; la sua popolazione era formata per il 35% da musulmani,
34% da croati, il 19% da serbi. Vi si registrava la più alta percentuale di
matrimoni misti di tutta la Jugoslavia. La minoranza serba aveva già abbandonato
la città quando i croati «ebbri di vino e di sangue si abbandonarono ad eccessi
di ogni sorta, ammazzando, saccheggiando e stuprando, per testimoniare il loro
odio verso tutto quel che era musulmano. Cancellarono praticamente il vecchio
quartiere turco, radendo al suolo ben diciassette moschee storiche, tra cui
anche quella di Asker-Mejid, la più antica della città.
Qualche mese più tardi venne distrutto a cannonate il Ponte Vecchio sulla
Neretva. Fatto costruire nel 1566 da Solimano il Magnifico, collegava il settore
musulmano di Mostar a quello croato situato all’altra parte del fiume
Il
disastro fu enorme e non solo dal punto di vista psicologico: il Ponte Vecchio
era infatti l’unico accesso alla fonte d’acqua potabile che si trovava nella
parte croata e alla quale la gente cercava di arrivare di corsa di notte,
sfidando il pericolo dei cecchini. Anche il mondo esterno rimase scioccato da
questo inutile atto di barbarie.
Il comando delle truppe serbo-bosniache era intanto passato a Ratko Mladic che
si era già guadagnato per le sue imprese in Croazia il poco invidiabile epiteto
di ‘macellaio di Knin’, destinato ad acquisire valore universale alla fine della
guerra.
Gli interventi dell’ONU, degli USA e dell’Unione europea, in quegli anni di
guerra, furono innumerevoli quanto perlopiù inefficaci: le risoluzioni, gli
ultimatum, i piani di pace, le minacce, mai mantenute, di intervenire con la
forza contro l’esercito serbo se avesse continuato le violenze contro i civili,
non si contavano più; la presenza dei caschi blu venne di fatto vanificata
dall’impossibilità di reagire con le armi alla ferocia a cui assistevano
impotenti. La popolazione incominciò a guardarli con odio, anche perché spesso
non erano immuni dalla corruzione dilagante.
Secondo fonti interne alle Nazioni
Unite, sono stati inviati, a proposito di crimini commessi dai
caschi blu in ex Jugoslavia, ben 140 dossier probatori all’allora vicesegretario
generale addetto alle operazioni di pace, Kofi Annan.
Invano i musulmani chiesero all’ONU che venisse eliminato l’embargo delle armi
per avere la possibilità di difendersi. Le armi tuttavia non mancavano a nessuna
delle parti in lotta, grazie al sempre più fiorente mercato clandestino. Intanto
in Bosnia cominciarono ad arrivare estremisti dall’Iran e da altri paesi
islamici per aiutare i fratelli bosniaci con i quali, probabilmente, in comune
non avevano nulla più che la fede religiosa. Con i dovuti distinguo.
Del lungo rosario delle risoluzioni ONU meritano di essere citate
la Risoluzione
808 che istituì un tribunale internazionale con sede all’Aja per «perseguire
persone responsabili di serie violazioni dei diritti dell’uomo nel territorio
dell’ex Jugoslavia a partire dal 1991»;
la Risoluzione 819 che dichiarava la
cittadina di Srebrenica «area protetta» e perciò «libera da ogni attacco armato
o da qualsiasi altra azione nemica», tutelata da un contingente di caschi blu;
la Risoluzione 824 che proclamava «zone di sicurezza» altre enclavi musulmane
come Tuzla, Goražde, Žepa; Bihac;
la Risoluzione 836 che autorizzava i caschi
blu a usare la forza per assolvere alle proprie funzioni e ampliava i compiti
della NATO, a cui si chiedeva di intervenire con raid aerei su richiesta della Unprofor. Inutile dire che anche queste risoluzioni si rivelarono del tutto
inefficaci perché spesso
mancava la volontà di tradurle in pratica proprio da parte di quello stesso
organismo che le aveva emanate.
Di conseguenza, «dopo che la Risoluzione 836
venne adottata, i serbi continuarono a bombardare le zone di sicurezza più o
meno con la stessa intensità di prima: Sarajevo ad esempio veniva colpita in
media 1000 volte al giorno, per lo più nelle aree abitate dalla popolazione
civile per causare il maggior numero di vittime e solo marginalmente per
danneggiare obiettivi militari.
Dei piani di pace si ricorda in particolare quello che porta il nome del
funzionario Onu che si trovava a dirimere la complessa faccenda jugoslava, Cyrus
Vance, e del rappresentante della Comunità europea lord David Owen. Il
cosiddetto piano Vance-Owen prevedeva una suddivisione della Bosnia in dieci
cantoni; ogni etnia sarebbe risultata prevalente su tre province. Sarajevo
avrebbe costituito un distretto autonomo. Accolto con grande diffidenza da serbi
e musulmani, che si sentivano fortemente penalizzati, il piano venne subito
accettato da Mate Boban perché la spartizione risultava favorevole ai croati,
anche se i gruppi più estremisti lo contestarono in quanto ritenevano che tutta
la Bosnia dovesse essere annessa alla Croazia. Di fatto il piano non venne
attuato anche se servì da punto di riferimento per i successivi che vennero
elaborati con il concorso
di altre potenze quali gli Stati Uniti e la Russia di Boris Eltsin.
Il 1994 fu l’anno di svolta in cui la diplomazia americana, sotto la minaccia di
far intervenire la NATO, portò croati e serbi a più miti consigli. Nel conflitto
croato-musulmano fece sentire la sua voce anche la Santa Sede, chiedendo un
riavvicinamento pacifico tra i due popoli. Mate Boban venne destituito dalla
presidenza dell’Herzeg-Bosna e Tudjman si rese disponibile a ritirare le truppe
croate dalla Bosnia, rinunciando all’annessione dell’Erzegovina. Anche per
Sarajevo si avvicinava la fine dell’assedio; Mladic, obbedendo agli ordini di
Belgrado, incominciò lo sgombero delle armi pesanti dalle alture intorno la
città, preludio dell’allontanamento definitivo dell’esercito serbo.
Sicuramente più che le rovine materiali della città distrutta, pesavano sui
sopravissuti le ferite psicologiche e la consapevolezza che l’impresa più
difficile sarebbe stata quella di far rivivere lo spirito multietnico e
tollerante di Sarajevo.
La città aveva perso gran parte dell’intellighenzia e
delle classi professionali, conoscendo una decadenza e un imbarbarimento
generale, il cui aspetto forse più tragico erano le bande di adolescenti e di
ragazzi che ne infestavano le vie. Una spia eloquente dell’estremo disagio, in
cui si trovava la popolazione, erano i traumi psichici, soprattutto le forme di
mania depressiva, di cui, a detta del professor Ismet Ceric direttore della
clinica
psichiatrica locale, soffriva almeno il 90% della gente. Più sconvolgente ancora
fu un rapporto dell’agenzia Reuters, secondo il quale molti bambini di Sarajevo
avevano sviluppato tendenze suicide e non prendevano alcuna precauzione per
difendersi dai cecchini, convinti com’erano che tanto sarebbero morti presto in
ogni caso».
Il 21 novembre 1995, gli accordi presi nella cittadina di Dayton posero fine al
conflitto. Alle trattative parteciparono le delegazioni delle tre parti in
lotta, guidate da Milosevic, Tujman, Izetbegovic; a fare gli onori di casa
Warren Christopher segretario di stato americano. La Bosnia Erzegovina veniva
riconosciuta come repubblica sovrana e autonoma ma divisa in due entità ciascuna
dotata di un proprio parlamento e governo: la Federazione croato-musulmana e la
Repubblica serba Srpska.
La Presidenza centrale della Repubblica è composta da tre membri eletti per
quattro anni, in rappresentanza delle tre etnie serba, croata, musulmana.
La pulizia etnica e i campi di concentramento
«Eravate così preoccupati di Sarajevo, che nel resto della Bosnia potevamo fare
quel che volevamo». Questa frase, riferita dal vicepresidente della Repubblica
serba Nikola Koljevic ad un inviato britannico, manifesta spietatamente
l’indifferenza con cui Belgrado accoglieva inviti e minacce della diplomazia
internazionale riguardo la situazione nel territorio bosniaco. Se si considera
poi quali frutti abbia portato la preoccupazione degli occidentali sul destino
di Sarajevo, il quadro è completo.
L’espressione ‘pulizia etnica’ si riferisce ad una somma di operazioni, compresa
l’eliminazione fisica delle persone, finalizzate all’allontanamento della
popolazione di un territorio occupato da truppe appartenenti ad una diversa
etnia.
Di questo crimine si macchiarono tutte le parti in lotta. Quando le vittime sono
civili inermi, non è semplice fare delle distinzioni in base a criteri
qualitativi e quantitativi. Tuttavia in Bosnia ci fu chi aggredì e chi reagì
all’aggressione. E il numero dei morti è una realtà di fatto, non una mera
supposizione.
Nel giro di poche settimane dall’inizio del conflitto, l’Armata popolare e i
gruppi paramilitari serbi riuscirono ad occupare circa il 60% del territorio
bosniaco agendo soprattutto nelle zone a confine con la Serbia, lungo la Drina.
Nella cittadina di Bijeljina, le truppe di Arkan gettarono delle bombe
all’interno della moschea, sterminando i fedeli che vi avevano cercato rifugio.
Cinquecento musulmani morirono durante i combattimenti che seguirono; i
sopravvissuti furono costretti a lasciare le loro case e a cercare scampo
altrove.
Spesso, vittime tra le vittime, sono le donne a subire una violenza tanto più
abietta, quanto più legata ad una forma di prevaricazione etnica; scrive in un
suo rapporto del 1993 Amnesty International: «Sebbene occorrano informazioni
ulteriori per completare il quadro e spesso non sia possibile verificare le
denunce, Amnesty International ritiene che stupri e violenze sessuali
perpetrate ai danni delle donne, per la maggior parte musulmane, da parte delle
forze serbe, siano avvenute in molte parti della Bosnia-Erzegovina, e che in
alcuni casi si sia trattato di azioni organizzate e sistematiche, con la
detenzione deliberatamente finalizzata a far subire alle donne
stupri e violenze.
Amnesty International ritiene che anche i musulmani e i
croati abbiano commesso tali crimini, anche se su scala assai minore».
Dal momento in cui si apre il conflitto con i croati, a loro volta vittime della
pulizia etnica operata dai serbi, la popolazione bosniaca subisce altri
attacchi, spesso mascherati da una blasfema strumentalizzazione della religione:
«All’alba de 16 aprile [1993] il villaggio di Ahmici, etnicamente misto, fu
attaccato da militi croati dalle facce dipinte di nero che uccisero,
sorprendendoli nel sonno, circa 100 dei suoi abitanti musulmani, molti dei quali
– anche bambini – furono arsi vivi, impiccati o massacrati in modo così orrendo
da non essere identificabili. L’iman locale, con la moglie, fu inchiodato sulla
porta della moschea e bruciato». Il villaggio venne raso
al suolo.
Un’altra realtà con cui si deve fare i conti è la creazione di nuovi campi di
concentramento nel cuore antico della civilissima Europa.
Nella città di Prijedor, nella Bosnia nord-orientale, i serbi sostituirono la
municipalità regolarmente
eletta con uomini di loro fiducia disposti a portare avanti la pulizia etnica
che distruggerà la realtà
sociale della regione. La Commissione di indagine sui crimini di guerra
dell’ONU, presieduta
dall’ex primo ministro polacco Tadeusz Mazowiecki, senza falsi eufemismi parlerà
di ‘genocidio’,
parola generalmente non gradita e accuratamente evitata dai diplomatici
occidentali.
Scrive Luca Rastello: «La campagna di pulizia etnica di Prijedor culmina
nell’apertura di almeno
quattro campi di concentramento: Omarska e Keraterm dove avvenivano
quotidianamente
uccisioni e torture, Trnopolje, utilizzato come transito in vista delle
deportazioni e luoghi di
ammassamento per donne e bambini (uccisioni e stupri avvennero anche qui), e
Manjaca definito campo per prigionieri di guerra, benché per la maggior parte i
detenuti fossero civili».
I racconti dei fuggiaschi o dei sopravissuti erano così terribili che si
stentava a dare loro credibilità
sino a quando non cominciarono ad apparire sui giornali europei i primi servizi
che documentavano
gli abusi e le sevizie inflitte ai prigionieri. La fama più sinistra è forse
quella del campo di Omarska
dove furono uccise circa cinquemila persone delle tredicimila internate.
Campi di concentramento furono creati anche dai croati e dai musulmani. A pochi
chilometri da
Mostar, i croati trasformarono una vecchia scuola di aviazione, Heliodrom, in un
lager dove
rinchiudere e torturare civili musulmani; nella cittadina di Tarcin, a cinquanta
chilometri da
Sarajevo, i musulmani bosniaci crearono un campo di prigionia dove «secondo
testimonianze di
serbi e croati, vi sarebbero stati rinchiusi numerosi civili e proprio in
occasione della chiusura del
campo nel novembre del ’93 sarebbero stati trucidati centodieci civili serbi e
un numero
imprecisato di croati. È indicato come responsabile dell’eccidio Safet Cibo,
inviato da Izetbegovic
nella zona in veste di commissario politico».
Srebrenica
Il nome Srebrenica ha un’origine antica che ricorda le miniere d’argento del suo
territorio. La lenta
agonia di questa cittadina sulla Drina dura quanto la guerra combattuta in
Bosnia: 1992-1995.
All’inizio del conflitto il centro abitato venne occupato dalle truppe serbe e
molti dei suoi abitanti
musulmani furono costretti ad abbandonarlo per cercare rifugio sulle montagne
circostanti.
Riconquistata dagli uomini di Naser Oric30, che si comportarono nei confronti
dei civili serbi non
meglio di quanto Arkan e i suoi si fossero comportati nei confronti dei
musulmani, Srebrenica
diventò un’enclave musulmana insieme ad altri centri della valle della Drina
come Gorazde e Žepa.
Nel 1993, la risoluzione ONU 819 la qualificò, insieme al suo circondario, ‘zona
protetta’ e perciò
vi furono inviati centocinquanta caschi blu che avrebbero dovuto garantirne la
sicurezza e
procedere alla smilitarizzazione delle forze musulmane. Di fatto, la città si
trovava sotto assedio e
non mancavano continui attriti con le milizie serbe che la circondavano.
Racconta Emir Suljagic,
interprete dei soldati ONU, scampato all’eccidio perpetrato contro gli abitanti
della cittadina: «I
cannoni serbi erano troppo lontani dalla città per poterli vedere, ma abbastanza
vicini per averne
paura, per far sì che ad ogni istante –ridendo o conversando- pensassimo al
suono assordante e
alla morte che portavano con sé, più rapidamente di quanto potessimo
immaginare». Le
condizioni di vita erano al limite dell’umana sopportazione: si soffriva la
fame, mancavano le
medicine, l’acqua, la corrente elettrica. Gli uomini spesso si avventuravano nei
villaggi serbi
circostanti alla ricerca di cibo; rischiavano la vita ma spesso erano i primi ad
uccidere. La gente
vendeva tutto ciò che aveva ai soldati ONU in cambio di un po’ di cibo; racconta
un testimone:
«Vendevano benzina, sigarette, cibo. A prezzi altissimi, l’unica cosa a buon
mercato era
l’immondizia: chiudevano la loro spazzatura in sacchi e vendevano i sacchi a
dieci marchi l’uno.
La gente là dentro crepava di fame, i sacchi se li compravano eccome».
Il 6 luglio 1995 i serbi attaccarono l’enclave, senza incontrare nessun ostacolo
da parte del
contingente olandese che aveva il compito di difendere i civili. Inutilmente il
comandante
Karremans chiese l’intervento degli aerei della NATO che, secondo la Risoluzione
836, avrebbero
dovuto garantire ‘l’assistenza aerea ravvicinata’.
La popolazione, ormai in preda al panico, cercò rifugio presso il quartier
generale dei caschi blu ma
solo qualche migliaio di persone riuscì ad entrare nel campo militare. In
quindicimila decisero di
abbandonare la città e recarsi a piedi a Tuzla, controllata dalle truppe di
Izetbegovic e distante una
cinquantina di chilometri. Per farlo dovettero attraversare un territorio
boschivo minato e presidiato
dai serbi. Dopo sei giorni di marcia, meno della metà di quelli che erano
partiti riuscirono ad entrare
a Tuzla in territorio amico.
A partire dal 12 fino al 19 luglio, a Srebrenica e nel territorio circostante,
incominciò la sistematica
uccisione dei civili. Morirono per mano di Mladic e dei suoi soldati circa
ottomila uomini, spesso
dopo aver subito torture e sevizie.
Per rispondere dell’eccidio di Srebrenica, Karadžic è comparso davanti al
tribunale dell’Aja il 26
ottobre 2009; Mladic è ancora latitante.
Il 31 marzo 2010, il parlamento serbo ha adottato una risoluzione in cui
condanna le atrocità di
Srebrenica e rende omaggio alle vittime, senza parlare però di genocidio.
Srebrenica oggi si trova nel territorio della Repubblica serba Srpska.
|
|